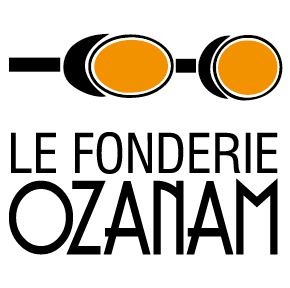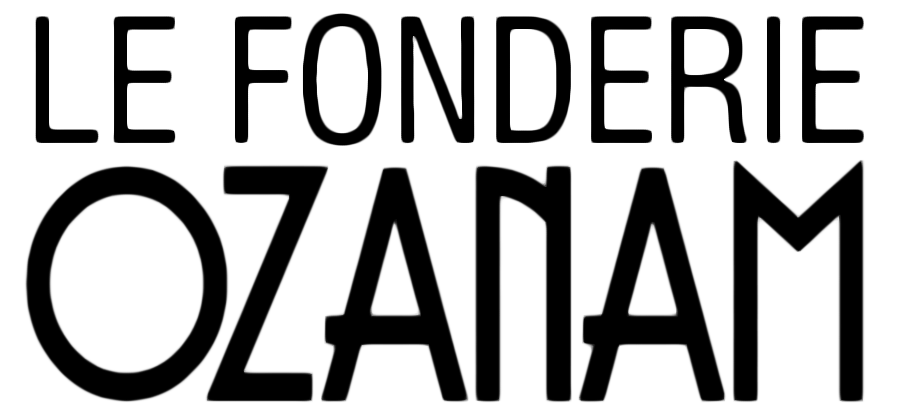Articolo scritto per il progetto cucine del Borgo da Alessandro Salvatico e Caterina Pira.
Ibrahim è slanciato e segaligno, un ampio sorriso e una nuvoletta di ricci neri animano il suo volto asciutto dagli zigomi scarni; accanto alla voce “somalo”, sull’enciclopedia, potrebbe trovarsi una sua foto. È bello e giovane, ma di quest’ultimo elemento tendi a scordarti dopo un po’ che lo ascolti; l’assennatezza dei suoi ragionamenti lascia straniti se si realizza che chi ti parla ha appena ventun anni, mentre la profondità delle sue parole non è comune incontrarla mai, a prescindere dall’età e della provenienza.
Si esprime in un italiano ottimo e fluente, che sorprende se si pensa che è arrivato in Italia meno di tre anni fa e prima parlava solo somalo. In aggiunta, un’innata simpatia completa un mix che affascina: Ibrahim è un ragazzo che ti tocca dentro.
La Somalia è un paese straziato da ogni sorta di disgrazia che possa colpire la terra. Dopo essere stato un oggetto passato di mano fra inglesi, italiani e francesi, ha conosciuto una guerra civile iniziata nel 1986 e mai conclusa, di cui al resto del mondo pare importare pochissimo; in questi anni ha conosciuto anche una vera e propria carestia, ed è sull’orlo del crollo per fame a causa del cambiamento climatico, un cambiamento di cui sono responsabili le popolazioni consumiste del Nord del mondo ma il cui prezzo viene pagato da questa terra.
Negli ultimi mesi, varie autobombe hanno mietuto centinaia di vittime innocenti, mentre un’invasione di locuste di proporzioni bibliche ha falcidiato le poche risorse rimaste: difficile immaginare qualcosa di più simile all’inferno sulla Terra.

Eppure, Ibrahim (o solo “Ibra” per gli amici) non l’avrebbe mai lasciata, se non vi fosse stato costretto. La sua storia è quella di un altro inferno personale che ha dovuto attraversare e che oggi va spesso a raccontare agli italiani in diversi incontri pubblici. All’inizio era recalcitrante, ma gli operatori del progetto di accoglienza in cui è stato inserito gli hanno spiegato che era una cosa importante. Lui lo ha compreso e oggi, quando capita, condivide la sua storia. “Anche se,” dice:
“non è facile vedere uomini più vecchi di me che piangono a causa delle mie parole. Ma so che le persone devono sapere che nessuno lascia il proprio paese e la propria famiglia senza ragione”
Nonostante tutto Ibra sorride, quasi tutto il tempo. “Ora sono in un posto dove non c’è guerra, finalmente. Torino è casa mia. Anche in Somalia ho dovuto cambiare spesso il posto in cui vivevo, ora la mia città è Torino e spero di non lasciarla mai!”. Ibra parla così, anche se l’impatto iniziale con il nord Italia non fu semplice.
Sbarcato in Sicilia, fu poi trasferito nel grande campo della Croce Rossa a Settimo Torinese, dove è giunto il giorno dell’antivigilia di Natale 2016. “Una volta arrivato ho chiesto: ma non è che ci hanno portato in Russia? Faceva un freddo incredibile, che non avevo mai sentito prima! Mi diedero un giaccone, ma io per uscire fuori me ne facevo prestare altri da qualche ragazzo e andavo in giro con tre giubbotti addosso, ridevano tutti…”.

Oggi è qui con noi in cucina a preparare i sambuus, o sambusi, sambosa, o ancora – come li chiamano gli indiani – samosa. Con quest’ultimo nome sono forse più noti, ma non tutti sanno che si tratta di una preparazione diffusissima in un’ampia zona del planisfero che va dal subcontinente indiano fino al Corno d’Africa. Il segreto del loro successo, visto che non risultano semplici né rapidi da preparare, può essere uno solo: sono una goduria per il palato. “Io li farcisco con la carne macinata, così sono molto più buoni”, afferma Ibrahim sicuro. “Altri li fanno alla maniera vegetariana e va benissimo se piacciono così, ma per me non c’è paragone con quelli ripieni di carne”.
I sambuus sono il piatto più importante della Somalia. “Se chiedi a un mio connazionale cosa si mangia giù da noi, lui risponderà subito, e sempre: i sambuus! Quando arriva qualcuno a casa tua, gliene fai trovare un po’, belli caldi. In periodo di Ramadan, quando la sera finalmente si mangia, per prima cosa ti pappi un po’ di sambuus”. Ci racconta che si trovano nei bar, nei negozi che vendono prodotti gastronomici, con la frequenza con la quale in Italia si trovano brioche e croissant nei caffè. “Solo che difficilmente si consumano al mattino appena sveglio, non esageriamo… Di solito li mangi più che altro per merenda, a metà pomeriggio”.
Realizzarli non è rapido, si diceva. Infatti Ibra ha già preparato l’impasto a casa. “Anche in Somalia, per essere sinceri, non molte persone hanno tempo o voglia di cucinarli. È più frequente che si comprino, tanto costano poco. Durante il Ramadan, quando se ne mangiano di più, le famiglie preferiscono prepararli a casa per risparmiare…”. Non si tratta di una procedura rapida e nemmeno così facile, ma Ibra ne padroneggia l’arte.
La motivazione c’è: “Io ho due sorelle più grandi che si sono sposate presto, mia mamma era rimasta sola a badare alla casa per cui dovevo aiutarla. Prima tagliavo solo la cipolla e rimestavo l’impasto, come un aiuto cuoco. Poi ho imparato, anche se a volte invece di mettermi a cucinare scappavo per andare a giocare a pallone”.

Le mani in pasta Ibra le ha sempre: ha seguito un corso professionale e oggi lavora in una nota pizzeria del centro cittadino.
“Quando sono arrivato avrei voluto studiare. Da piccolo non ho potuto farlo, avrei voluto riuscirci ora e riuscire un giorno a frequentare l’università: sogno di studiare farmacia. Intanto ho preso la licenza media, dovrei iniziare le superiori”.
La sua stupefacente maturità lo guida: “Adesso non potrei farlo però, perchè ho bisogno di lavorare e mantenermi. Ma so che potrò in futuro, non sono per forza costretto a diventare un dottore in tempi brevi. E poi, in un certo senso, sto studiando comunque, anche ora. Ed è uno studio molto utile per il mio futuro”. Cosa studi? “Impasto. Vorrei imparare tutto dell’arte della pizza, c’è tantissimo da capire. Secondo me ce la farò”. E coltivare dei dubbi, per chi lo ascolta, è davvero difficile.
Intanto Ibra ha ricavato dei dischi sottilissimi di impasto, che poi taglia ricavandone quattro triangoli. Li dispone sulla piastra rovente, accoppiati l’uno sull’altro e voltandoli con un tocco fugace. “I sambuus piacciono sempre a tutti”, sorride sicuro. “Quando uno li assaggia per la prima volta se ne innamora, un po’ come una persona che arriva in Italia e affonda i denti in una pizza napoletana: subito pensa che è buonissima”.
Un vero amore, quello di Ibrahim per la pizza: “Ne mangio tantissima! Sono cresciuto con i sambuus, ma ora la mia vita è la pizza. Se dovessi scegliere fra i due non ne sarei capace… Sono parte di me, sono la mia destra e la mia sinistra!” chiosa con filosofia, mostrandoci entrambe le mani, i palmi rivolti verso l’alto, le dita lunghe e sottilissime.
Prima del lavoro, prima della scuola, Ibra è stato accolto in un CAS, un Centro di Accoglienza Straordinaria, le strutture dove le persone richiedenti protezione internazionale vengono inserite in attesa che la loro richiesta venga vagliata da una Commissione Territoriale. Alla fine, quella di Ibrahim è stata accolta e gli è stato riconosciuto l’asilo politico. “Ci sono tanti ragazzi stranieri, nigeriani per esempio, che riferendosi al fatto che ho ottenuto i documenti mi dicono: sei fortunato! Lo so che vedersi respinta la domanda non è bello, resti senza un documento qui in Europa e non puoi più fare nulla…”
“Ma io non mi sento fortunato. A me fa male, quando lo dicono. Nel mio paese c’è la guerra e non posso stare con la mia famiglia, non mi sento fortunato per questo”.

Fortunato no, ma felice comunque sì. “Qui è proprio bello”, dice con parole semplici e un sorriso grande. Abita vicino a Porta Palazzo, e ha tanti amici che, a suo dire, “sono la cosa più importante di tutte”. E lì, nel mercato all’aperto più fornito d’Europa, non gli manca nulla: “Posso trovare ogni ingrediente al mercato, è stupendo. Quasi ogni ingrediente”. Il “quasi” si sostanzia nella descrizione che ci fa di un frutto della sua terra, “tendente al giallo, fatto così”, disegna in aria con le mani, “e giallo all’interno, col nocciolo, dal sapore sia dolce che salato… Ma non ricordo come si chiami, ho scordato anche il somalo”, ride, con un luccichìo di malinconia negli occhi. Quando stai tanto lontano da casa, inizi a perderne dei pezzi per strada.
Ibrahim farcisce i triangolini di impasto con carne, verdure e spezie. “Io li faccio così. Se un indiano mi dice che si fa cosà gli direi che questa è una ricetta somala, e di farsi gli affari suoi!” e prorompe in una risata, stavolta di puro divertimento. “Scherzo, in realtà è un piatto così diffuso che nessuno sa con certezza dove sia nato. Anche in Somalia ognuno lo fa a modo proprio, ma questo qui è quello classico”. Prima di farcirli, Ibrahim ha sigillato i triangolini con un movimento che ha calamitato i nostri sguardi: ha intinto il dito in mix di acqua e farina, lo ha passato sui margini del triangolo ripiegandoli un istante dopo. A questo punto, i bordi dei sambuusi sono cementati: non si apriranno, una volta tuffati nell’olio bollente.
A Torino Ibra si è fatto tanto amici e non è difficile da credere: simpatia e profondità fanno di lui una splendida compagnia. “Domani andiamo a Boves”, ci racconta, “per commemorare il ricordo dei partigiani”. Ma c’è anche una ragione più materiale per le sue tante amicizie: “Faccio abbastanza bene la pizza”, dice con modestia, “quindi spesso mi chiedono di prepararla. Dove abitavo prima, al centro di accoglienza, io e un altro ragazzo ne abbiamo fatta per centocinquanta, duecento persone! Non solo pizza, ma anche piatti somali: i sambuus e poi anchera, sabayad, muufo... Il mio amico somalo si è messo a mangiare con le mani, tutti si sono messi a fissarlo, lui se n’è accorto e ha chiesto: “Tutto bene?” e tutti a ridere. Allora abbiamo spiegato la cultura somala, il nostro modo di mangiare, con le mani, appunto”.

I sambuus sono rapidamente fritti, il loro aspetto è perfetto: sembrano preparati con un macchinario apposito, con una stampante 3D. Se non fosse per il profumo che emanano, che non potrebbe uscire da nessuna apparecchiatura tecnologica: è dura attendere qualche secondo, per evitare di ustionarsi il palato, prima di addentarli.
Una volta inferto l’agognato morso, il risultato è pari alle aspettative: sono tanto buoni quanto belli, aveva ragione Ibrahim ad affermare che “piacciono a tutti”. A noi, piacciono così tanto che solamente dopo ci accorgiamo, con un pizzico di vergogna, che al nostro cuoco ne abbiamo lasciato solamente uno… Ce ne scusiamo e lui si schermisce dicendo “Ma non mi piacciono poi così tanto”, concedendo al nostro appetito un’attenuante poco credibile.
Nella cultura somala di cui sopra, peraltro, esiste anche anche la pastasciutta, retaggio felice dell’infausta colonizzazione italiana. Ma anche questa è stata declinata in salsa locale: molto comune è infatti preparare gli spaghetti…con le banane. “È un fatto di cultura un po’ buffo, non è vero?”, sorride Ibrahim. “Ho provato a farli qui per gli amici, a qualcuno faceva strano ma ad altri sono piaciuti! Capisco sia insolito, ma bisogna sempre provare, non essere chiusi. E’ come quando qualcuno parla di pizza con l’ananas; un mio amico della Germania mi assicura che sia buona. Una volta me l’ha persino cucinata…” Gli domandiamo se l’abbia provata, per non sembrare chiuso. “Non ci penso proprio!” risponde lui divertito, “Sarà buona per i tedeschi, ma…che schifezza!”.