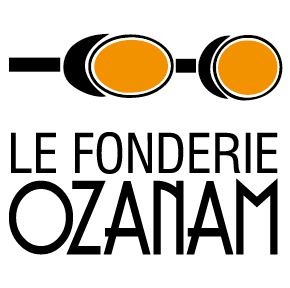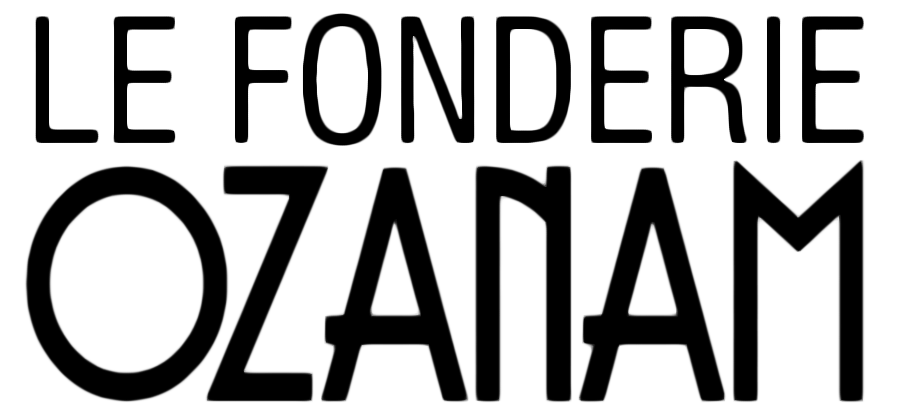Articolo scritto per il progetto cucine del Borgo da Alessandro Salvatico e Caterina Pira.
“Da quale città della Cina vieni?”
“Vengo da zhchwyung” (un indefinito suono cinese alle nostre orecchie)
“Che si trova dove?”
“Nello Jiangsu”.
“Quindi…dove?” (le nostre gote si tingono color ignoranza)
“…Vicino a Shangai”.
“Aaah! Shangai, ok, ci siamo”.
“Sì, è a sole 8 ore di autobus!”
“…”
La giovane, minuta Lin ci mette subito nell’ordine di idee delle dimensioni del suo paese, dove il concetto di “vicinanza” è piuttosto relativo.
È in Italia da meno di un anno, non parla benissimo la nostra lingua ma a noi sembra già notevole quel che è riuscita ad apprendere in un tempo così breve, specie alla luce della pessima prova di cultura generale che noialtri le abbiamo offerto pochi istanti prima. Per la cronaca: la sua città è Lianyungang, nome che in mandarino significa “il porto collegato alle nuvole”, visto che sorge su una baia di fronte a un’isola marina con un’alta montagna alle spalle. E non si tratta di un borgo misconosciuto, ma di una metropoli di quasi 5 milioni di abitanti.
Andiamo insieme a raccogliere un po’ di erba cipollina nella coltivazione che OrtiAlti ha realizzato sul tetto del ristorante per la ricetta. Una volta scesi, Lin inizia a versare l’acqua in mezzo alla farina: è l’impasto per i jiaozi, che da noi sono famosi come “ravioli cinesi”.
Lin non parla molto: oltre alla conoscenza ancora imperfetta dell’italiano, c’è anche una timidezza evidente. Anche mentre il panetto riposa per riprendersi dallo stress della manipolazione, interagire con lei non diventa comunque semplice né soprattutto immediato.

Si concentra su quel che fa, e a noi non resta che fare lo stesso: è stupefacente ammirare la perfezione dei dischetti di pasta che ricava, appiattendoli prima con una mano e poi girandoli velocemente sotto al mattarello in movimento.
Lo scorrere dei minuti e la barriera linguistica ci costringono a osservare, e basta. Ma così facendo, siamo anche portati a spostare il dialogo su un piano diverso, e ci rendiamo conto che in fondo l’abitudine di valutare una e una sola strada come opzione per comunicare è limitante.
Ci troviamo qui, sul nostro territorio, nello stesso humus culturale che ci ha nutriti e dal quale siamo sbucati, e siamo curiosi di comprenderla; lei al contrario è arrivata qui da poco costretta dagli eventi, è sola, ha necessità di comprenderci. Abbiamo un solo tramite per riuscirci: il cibo. Quando Lin ci illustra come si compiono i vari passaggi che ci porteranno ai jiaozi, vediamo svelarsi un’insospettata sicurezza caratteriale.
Il giro che i ravioli compiono fra le sue dita per essere più volte pizzicati e sigillati è rapidissimo. Le facciamo capire che vorremmo vedere il movimento “al rallenty”, per poterlo capire, e lei decelera. Una volta farciti e chiusi, Lin pone i jiaozi nella wok rovente. Quando al velo d’olio bollente aggiunge dell’acqua, il mix provoca all’istante rumore, fumo e uno sfrigolio potenti, subito tappati con un coperchio. Ed è sempre con un gesto che risponde alla nostra domanda “Come sai quando sono pronti?”. Lin si china verso il tegame inclinando il capo, quindi con un dito traccia una linea immaginaria che collega la pentola all’orecchio: proprio a causa della baraonda in corso dentro la wok, sarà il rumore a dirle quando i jiaozi saranno cotti.

È forse la prima volta che vediamo un cuoco che, anziché assaggiare od osservare, ci invita ad ascoltare per sapere se la cottura è arrivata a termine. Tra sfrigolii e rumori metallici, Lin prepara più di trenta ravioli e noi li mangiamo tutti. Sono pazzeschi.
Ci sediamo con lei e pian piano iniziamo a comunicare anche con le parole. Lei si rilassa, inizia finalmente a sorridere e si sforza di usare tutto l’italiano di cui è capace. Ci dice che le piacerebbe che nell’orto ci fosse dello zenzero, ma anche una serie di altri ortaggi cinesi che noi conosciamo poco o punto, come la luffa (parente orientale di zucche e zucchine) e altre erbe misteriose.
Fra un termine cinese e l’altro, scopriamo che “Lin” è in realtà il suo cognome, non il nome, che è invece “Xiochue”. Ma, anche per evitare errori di pronuncia, decidiamo di continuare a chiamarla Lin, e lei non ha nulla in contrario; d’altronde è lei stessa a presentarsi così, conscia delle contorsioni che il suo vero nome richiederebbe alle nostre lingue.
Intanto i jiaozi sono terminati, purtroppo. “I ravioli in Cina sono importanti”, ci racconta.
“Quando c’è una festa, quando vuoi fare gli auguri a qualcuno, oppure a Capodanno, si fanno spesso. Così come per salutare una persona che si trasferisce in un’altra città. Voi magari per festeggiare qualcosa o qualcuno preparate una torta; noi, facciamo i ravioli!”.
La cucina cinese, ricca e sfaccettata come forse nessun’altra al mondo, è in effetti povera di dolci. E nonostante questo (o forse proprio per questo) a Lin piacerebbe imparare a prepararli, perché, nonostante non siano parte del suo bagaglio culturale, torte, pasticcini e semifreddi le sono piaciuti molto, sin dal suo arrivo a Torino. Città dove, peraltro, si trova benissimo: “Non ho visto tanti posti, né in Italia, né in Cina. Ad esempio, non sono mai stata a Pechino. Ma posso dire che Torino, anche se piccola, è meglio di Milano!”.
Come accade spesso, un piatto “quasi nazionale” è anche un fattore di socialità. “Tu vieni a casa mia,” ci racconta Lin, “io metto la farina, tu un altro ingrediente, lui qualcos’altro ancora… Ci si divide i compiti, uno impasta, uno bada al fuoco, si parla e si ride, ci si insegna e si è felici! Non è bello farseli da soli in casa!”.

Mentre dice queste cose sembra ancor più ragazzina: e torna ad essere una bambina in un distretto di Lianyungang quando ricorda come ha imparato a preparare i ravioli: “Guardavo la mia mamma e il mio papà, lui era molto bravo a farli e me lo insegnava, io ero emozionata e ci provavo. All’inizio, era solo per giocare; ma poi, giocare diventa imparare”. Oggi Lin è diventata abile e ne è consapevole: “Le mie amiche non li sanno sigillare bene come me!”, ma conosce persone ancora più esperte che quando chiudono i jiaozi sanno addirittura realizzare dei disegni decorativi.
Lin ci annuncia che a un nostro prossimo incontro le piacerebbe prepararci degli involtini tipici dello Jiangsu, simili a quelli che nei ristoranti cinesi dal gusto occidentalizzato che proliferano in Europa chiamiamo “involtini primavera”. Eppure, ci confida, non vorrebbe fare la cuoca per mestiere: “A casa cucino molto, ma in Italia vorrei fare la barista”, afferma. Ha frequentato un corso professionale per imparare questo lavoro, da quando è arrivata.
Vorrebbe imparare a cucinare italiano, “Ma non sono capace!”, si schermisce. In ogni caso, ci ripete, la sua scelta professionale cadrebbe su “caffè e cappuccini”, più che su ravioli e involtini.
La cucina cinese e quella italiana sono unanimemente considerate fra le migliori a livello globale. Molti qui apprezzano i piatti orientali e scopriamo che allo stesso modo la giovane Lin ne ama parecchi fra quelli nostrani, su tutti la pizza e le lasagne. C’è un filo conduttore tra le due culture gastronomiche, un vero filo, non in senso figurato: lo spaghetto. Considerato simbolo dell’italianità nel mondo, è in realtà un’invenzione tutta cinese portata nel bel paese da Marco Polo. La nostra protagonista li saprebbe preparare, ma non ha alcuna intenzione di farlo: “È troppo lungo…troppo lavoro!”, e ridendo aggiunge che si limita a divorarli quando qualcuno glieli prepara. Esattamente come la stragrande maggioranza di noi.