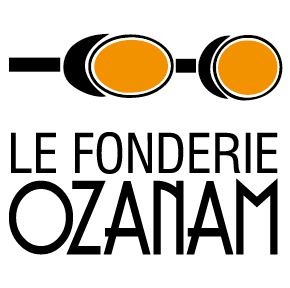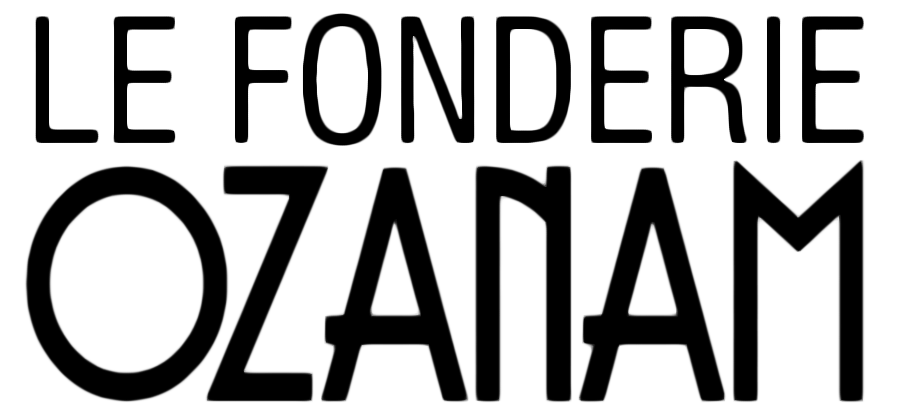Articolo scritto per il progetto cucine del Borgo da Alessandro Salvatico e Caterina Pira.
Quando Nadine apre la porta della cucina, ai nostri occhi appare una donna dall’aspetto gagliardo. Le braccia forti, il bel viso messo in risalto da un taglio di capelli molto corto, senza fronzoli, evidenziato da una colorazione giallo platino. È visibilmente incinta e lo sguardo deciso fa capire che questo dettaglio non rallenta né tantomeno ferma la nostra protagonista.
Quando apre bocca, però, la sua immagine cambia: la voce è dolce, pur lasciando intuire di potersi trasformare in tuono quando deve governare l’ampia famiglia. Il suo ottimo italiano è impastato di un’adorabile cadenza francofona. Su tutto scorre la sua risata, una risata argentina con cui colora e ingentilisce quasi ogni cosa che dice. Le cose belle e quelle meno belle.
“Abito non molto lontano da qui”, ci dice, “e mi trovo bene”. Nadine ha condotto e conduce una vita faticosa, lavorando duro. Ha due figlie, più una in arrivo; ma presso le cucine qui in Ozanam è venuta accompagnata da un maschietto di otto anni: il suo nipotino, venuto a trovarla dalla Germania, è un bimbo mingherlino e simpatico con cui comunica in francese.
Oggi Nadine ci preparerà e racconterà la ricetta dei légumes sautés, nome che – a proposito di lingua, per i non francofoni – non ha nulla a che fare con i legumi: significa semplicemente “verdure saltate”. Ma è molto più di questo, come ci riveleranno presto prima i nostri occhi e poi i palati.

Inizia a lavare gli spinaci con cura, poi di nuovo e poi un’altra volta ancora. Sembra quasi un eccesso di pulizia, forse figlio del suo lavoro a contatto col pubblico: Nadine è cuoca, o meglio lo era.
Prima di trasferirsi a Torino nel 2013, ha vissuto e lavorato per nove anni in un locale di Perugia, di cui ha ricordi a un tempo piacevoli e massacranti. “Era molto grande, faceva da ristorante, pub e pizzeria, e in cucina eravamo solo in due… A volte cucinavo e piangevo, avevo male dappertutto; per questo non vorrei più fare quel lavoro”. Infatti Nadine ha appena terminato un corso per ottenere la qualifica di OSS, operatore socio-sanitario. Ma cucinare, di per sé, le piace:
“Oggi sono venuta fin qui, anche col pancione, proprio perché adoro preparare buoni piatti: non mi pesa. Ho finito da poco il periodo di tirocinio, dove dovevo stare otto ore in piedi o, peggio, otto ore seduta: quello era faticoso!, non questo”.
Nadine inizia a sminuzzare carota, sedano, cipolla e pomodoro per il soffritto, mentre gli spinaci, lessati e poi scolati, cercano di fare ciò di cui molte persone fanno uno dei buoni propositi di inizio anno: smettere di fumare. A quel punto, freddatisi, Nadine potrà strizzarli e tagliarli sottili. I suoi occhi vedono gli spinaci ma sognano foglie diverse, simili nell’aspetto ma non così vicine nel gusto, erbe e verdure che crescono laggiù, a pochi passi dall’equatore.
Solitamente in Camerun per questo piatto si utilizza il folong, una verdura a foglia cui oggi lo spinacio ha usurpando il posto in pentola, che sarebbe più adatta allo scopo e che Nadine ci dice essere buonissima (e pensare che negli USA considerano questa pianta – l’Amaranthus hybridus – un’erbaccia da estirpare). E poi lo ndole, con cui si prepara l’omonima ricetta, che si può considerare il piatto nazionale del Camerun.

Si tratta di una ricetta piuttosto complessa: uno stufato di arichidi, che vengono bollite, triturate e ridotte in crema, servito con gamberetti, pesce secco o carne di manzo. Lo ndole ne è, insieme alle arichidi, l’unico ingrediente fisso. Documentandoci in seguito, scopriamo che si tratta della Vernonia amygdalina, un’altra verdura a foglia, dal sapore intenso ma dal gusto superficiale così amaro che va edulcorato con lavaggi ripetuti e intensi. Ecco svelata d’un colpo l’origine dell’accanimento igienico di Nadine sugli spinaci.
Queste e altre verdure del Camerun non si trovano facilmente a Torino, ma quando suo cognato torna in Africa per lavoro e se le procura, ecco che Nadine cerca di andare a trovare la sorella in Francia per farsene dare un po’. Allora, per un periodo, può replicare esattamente i piatti del suo paese, di cui ci facciamo raccontare molto, sapendone di fatto assai poco.
Per esempio, scopriamo che il pasto non avviene con la condivisione del cibo da un unico grande vassoio come spesso nel nostro immaginario comune sull’Africa. In diversi paesi accade effettivamente così, ma in Camerun ciascuno ha il proprio piatto, come in Europa. Rispetto al numero di pasti quotidiani, Nadine ci risponde che c’è chi fa colazione, pranzo, merenda e chi fa un unico pasto: “Ma non è questione di gusti o preferenze: molti non hanno i soldi per mangiare più di una volta al giorno…”.
Il profumo della carne di maiale che sfrigola nel soffritto ci riporta al momento presente. È un aroma delizioso, ma Nadine racconta di una signora sua vicina di casa che, quando lei cucina, esce a spruzzare profumi e deodoranti per le scale del condominio per non sentire le fragranze che emanano i suoi piatti.

Piccole storie di razzismo quotidiano che ci amareggia sentire, ma che la cuoca ci riferisce allargando le braccia con una risata. Lo fa con la saggezza di una donna di mondo, che non si sofferma su meschinerie simili.
“Se oggi avessi cucinato a casa mia, i légumes sautés li avreste trovati molto, molto piccanti… ma ho cucinato qua!”, rivela sottintendendo “per vostra fortuna”.
Usa con maestria anche le erbe e le spezie italiane che, ci racconta, acquista nei negozi fra Borgo Vittoria e Madonna di Campagna. Poi si ferma un istante e con semplice profondità riflette: “Alla fine, usiamo quasi tutti gli stessi ingredienti! Il pepe nero o bianco, lo usiamo; l’aglio, lo usiamo; la cipolla, il peperoncino… Abbiamo quasi tutti gli stessi elementi di base, poi ognuno ha il proprio modo di prepararli. È lì che stanno le differenze, ma le basi sono le stesse!”. Razzismo disinnescato a colpi di cipolla.
La cottura è quasi ultimata, Nadine decide di viziarci preparando un contorno di platano, in parte lesso e in parte fritto, offrendoci così ancor più varietà di sapori. “Quando cucino per qualcuno che so non amare il platano, lo sostituisco con le patate”, ci spiega. Ma nel nostro caso, non c’è di che preoccuparsi.
Lo scorso anno, un paio di volte al mese partecipava a degli eventi in cui cucinava piatti tipici per la comunità camerunense locale. È l’unica eccezione al suo fermo proposito: non lavorare più come cuoca. Non dimentica la fatica dei suoi anni perugini, quando il cuoco se ne andò e il proprietario non lo sostituì, lasciando tutto sulle spalle di Nadine. “Io ho lavorato anche nei campi”, ammette, “ed è meno faticoso che in cucina! Nei campi almeno non devi impegnare anche la testa, badando a tutto quello che gli altri vogliono o non vogliono o potrebbero pensare”.

Non tornerà a lavorare in un ristorante, ma il cibo resta per lei un grande amore ricambiato.
“Cucino quasi tutti i giorni, a casa. Per me la cucina è arte, è creatività”, dice con gli occhi che sorridono.
Le sue figlie hanno atteggiamenti diversi: la più grande ama muoversi tra fuochi e pentole e apprezza la cucina ancestrale, la seconda non è interessata e preferisce mangiare solo italiano. “Se non le faccio abbastanza spesso le lasagne, si arrabbia!”.
Un piatto tira l’altro e quando le chiediamo cos’altro potremmo cucinare insieme, Nadine ci racconta di una lunga serie di dolci del suo paese: il bigné soufflé, l’amuse gueule, la torta all’arancia, allo yogurt e all’ananas, dei dolciumi a base di semola e banana, un dessert un po’ salato a base di fagioli, da consumare a colazione. E poi c’è un piatto molto celebre nel suo paese, il Poulet D.G., a base di pollo, platano e verdure, che Nadine afferma essere squisito.
Si sente spesso dire che il cibo è cultura, tradizione e storia; noi ne siamo assertori convinti. Nonostante ciò è abbastanza raro, anche per noi, trovarne riscontri già a partire dal nome della ricetta, come in questo caso: “D. G.” è l’acronimo di Directeur Général, figura amministrativa del vecchio apparato coloniale francese, e indica in maniera lampante che si trattava di un piatto per ricchi, da dedicare alla visita di una figura importante..
Quando si toccano questi aspetti, sul viso levigato di Nadine si contraggono muscoli che lo segnano di linee nervose. “Sono più di tre anni che non torno in Camerun”, sussurra. “Se mi manca? Certo, è casa mia. Su questa Terra siamo tutti migranti, lo sapete; ma se fossi stata bene a casa mia ci sarei rimasta! Non sarei venuta qui. Se l’Europa avesse lasciato l’Africa un po’ in pace, senza venire a creare guerre e sofferenze…”, nella sua voce c’è un tono di amarezza.
Poi, decide di sputare quel grumo di rabbia che stava tenendo in gola: “La Francia ha rovinato il Camerun. Dicevano che la schiavitù era finita, ma non è vero! La colonizzazione è una forma diversa di schiavitù, un altro non dovrebbe poter decidere per te. I francesi decidono i prezzi di legname, cacao, caffè… Abbiamo tante risorse, ma non decidiamo noi. Il presidente è lì da quando sono nata: non ha senso! Non è possibile nascere, crescere, invecchiare e conoscere un solo presidente! Non ha senso, no!”.

A stemperare la stizza ci pensa il cibo. Il quale, oltre che storia e cultura, sa anche essere balsamo e medicina. È tutto pronto: i profumi della verdura, della carne e delle erbe partono distinti per poi fondersi all’altezza delle narici, fra i denti il gusto è vivace e accogliente, ha un che di “materno”.
Chiediamo a Nadine chi le abbia insegnato a cucinare così: “Mia mamma!”, risponde, ridendo per la sciocchezza della domanda. “Giù da noi cucinano solo le donne. Gli uomini ai fornelli? Ah, ah, ah!”, e giù a ghignare più forte. “Qui può succedere, ma da noi no, le donne fanno tutto in casa. Poi arrivi in Europa e…non cambia niente: continuo a preparare tutto io. Ma le mie figlie no, non sono d’accordo su questo; loro sono giovani”. A volte una sola generazione è sufficiente perché avvenga una transizione culturale.
E per alcuni cambiamenti, anche una sola vita. Mentre mangiamo gli spinaci, Nadine ci rivela che spesso li cucina alla maniera italiana, con meno spezie, con sale, pepe, e quella cosa strana chiamata “formaggio”, che non consumava affatto in Camerun e ha iniziato ad apprezzare in Italia.
Piano piano, ma nemmeno tanto: “Quando ho poco tempo faccio una pasta al sugo, tanto alle ragazze piace. Giù da noi il passato di pomodoro si fa cuocere per ore, aggiungendo una serie di erbe e sapori forti, per cui la salsa come si fa qui mi sembrava strana al palato, inizialmente, così dolce… Ora la preparo sempre all’italiana, e quando vado in Camerun non riesco più a mangiarla come la fanno là… Mi sono talmente abituata alla maniera italiana, che mi dispiace ma ormai in un altro modo non riesco proprio più a mangiarla!”.