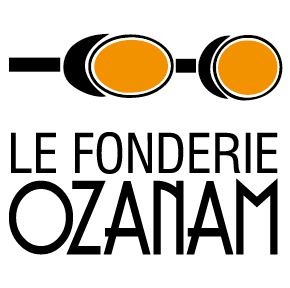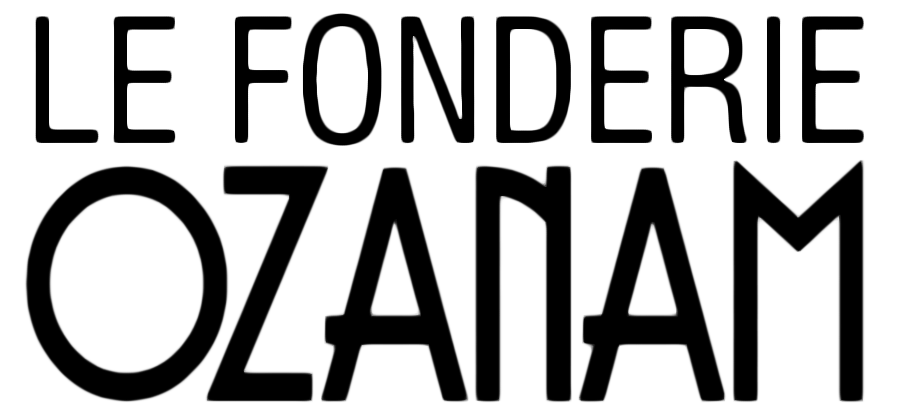Articolo scritto per il progetto cucine del Borgo da Alessandro Salvatico e Caterina Pira.
“È che non mi fido tanto del tavolo…”, mormora Pina con l’accortezza di chi bada a non offendere l’interlocutore. Che nel caso specifico siamo noi, un po’ sorpresi nell’osservare questa sua diffidenza di fronte all’ampio piano di marmo della cucina professionale che le è stata messa a disposizione per preparare i suoi strascinati mollicati con aglio e menta. Ma non c’è alcuna offesa nella sua perplessità e lo stupore si estingue davanti alla spiegazione che ci forniscono lei e il figlio Gianluca.
Ci sono due ordini di motivi dietro lo scetticismo di Pina. Il primo è prettamente tecnico: sarebbe stato più indicato un piano ruvido, magari in legno. Questo perché sul marmo la pasta scivola troppo, al momento in cui la si deve strascinare per darle la forma.
La seconda motivazione invece rientra in una sfera del tutto impalpabile. Il tavolo che la signora Pina utilizza a casa propria infatti non è semplicemente “di legno”: se l’è portato fin qui dalla Lucania, lo aveva costruito suo padre falegname.

Tutti avranno sentito dire che un piatto non riuscirà mai buono altrove, come invece riesce se realizzato nei luoghi in cui è nato. L’affermazione è spesso argomentata da un riferimento alla diversa qualità delle materie prime.
Ma qui, siamo oltre: “Anche il legno è di giù”, dicono,
“Secondo noi fa differenza. Ci sono degli ingredienti invisibili, che sono gli attrezzi, ma anche i ricordi”.
Gli ingredienti invisibili, dunque; alcuni hanno una valenza fattiva, altri forse no ma non per questo sono meno importanti. “Non è detto che una rotella fabbricata mezzo secolo fa tagli davvero diversamente da una uscita da una fabbrica cinese il mese scorso”, soggiunge Gianluca, “però quella è attaccata a noi…”.
“Abbiamo scelto di cucinare gli strascinati”, annuncia Pina con la pronuncia ideale che va a trasformare in “d” l’ultima “t” e accorcia o cancella le vocali, praticamente “strashnàd”. Li faranno mollicati, con aglio e menta, “una ricetta veloce veloce, da fare quando si ha poco tempo”.
Il fulcro è la pasta, il condimento può variare a piacere: ci suggeriscono carne, salsiccia, verdure, fagioli, patate… La scelta di quest’oggi deriva dall’essere un piatto contadino, semplice, “come mia mamma e le mie nonne lo facevano sovente, perché non c’erano abbastanza soldi per comprare altro”.
E per fare questo piatto, non bisognava comprare proprio nulla: la famiglia coltivava il grano, ne ricavava la semola e da questa la pasta. Ogni santo giorno. Tanto è vero che, in un mondo all’incontrario rispetto al nostro stile di vita attuale, spesso alla domenica per festeggiare si mangiava la pasta industriale, quella comprata in negozio.
“Quando vedo mia mamma mettersi a fare queste cose”, ricorda il figlio, “la mente corre a momenti della mia infanzia, quando passavo le estati giù al paese e nonna e le varie zie si mettevano a fare la pasta. Quanta ne facevano! Chilate e chilate di pasta, tant’è che poi siamo diventati tutti grassi!”, mentre la mamma ride e lo rimbrotta amorevolmente, per poi affidargli la preparazione del condimento.

“I miei nonni erano contadini, tenevano qualche bestia e vivevano della campagna”. Continua a raccontare Gianluca, “non buttavano mai via niente: ed ecco appunto il pane raffermo che diventa quella mollica sbriciolata che useremo oggi. Andavano nei campi e prendevano la menta, l’aglio invece lo avevi sempre; e basta, tutto qui quello che serve. Tutto sull’uscio di casa”.
Ci volgiamo a guardare la mamma e sembra che stia…pregando, mani giunte davanti a sé. Un’invocazione a Cerere, dea dei raccolti e del grano? Al Flying spaghetti monster dei pastafariani? Un rito lucano per favorire la buona riuscita del piatto? Tutt’altro, stiamo assistendo a un’operazione quasi scientifica. Molti dei bravissimi chef casalinghi che abbiamo incontrato pesano a occhio; ma oggi la nostra cuoca utilizza una precisa unità di misura.
…Solamente, si tratta di un’unità a noi sconosciuta: “La chiotta!”. Pina vede che la stiamo osservando, ride e posa le manciate di semola sul tavolo.
“Noi per pesare la farina usiamo le mani giunte, questa misura la chiamiamo chiotta e ogni chiotta è una persona”.
Il figlio conferma trattarsi di una vera e propria unità di misura, “perfetta e internazionale, anche sui ricettari potreste trovare “aggiungere tot mani giunte di Pina”, a indicare le dosi”. E poi aggiunge: “Ma la quantità giusta è questa, la mano sua, non una mano in generale. Se sei un uomo, devi considerare una dose minore di semola”.
Gianluca ore vive a San Salvario, ma per un tratto della sua vita, via Foligno 14 è stata quotidianità: lavorava nell’ostello che ora ospita ventitré ragazzi stranieri, migranti proprio come sua mamma, con la sola differenza della lunghezza del viaggio, ma sempre lontani da casa.
Mentre Pina impasta, lui afferma che questo per lui è “un luogo fantastico, al suo interno ci sono tanti progetti: c’è un OrtoAlto sul tetto di un ristorante gestito da una cooperativa sociale, ci sono persone che vengono da posti diversissimi… è come una grande tavola” con i profumi del ristorante, dell’ostello, di queste cucine che ospitano meraviglie da tutto il mondo, e “ogni volta che entri, incontri qualcosa”.
Ma…cos’è successo? Ci è bastato distrarci un attimo per ascoltare questa riflessione, che accanto a noi è stato compiuto senz’altro un sortilegio: non è possibile, diversamente, che sia comparsa sul tavolo la moltitudine di strascinati che abbiamo di colpo davanti agli occhi.
L’impasto è quasi esaurito, per fortuna sono rimaste ancora un paio di “bisce”, come le chiama Pina, che aspettano di cambiare forma. Il figlio ride del nostro stupore: “E dovreste vedere quando si mettono insieme tutte le mie zie, quanto sono veloci, vanno a cinquemila!”.
La cuoca è consapevole della propria abilità. “Ho imparato da mia mamma e dalle nonne quando avevo sette anni, quindi è da oltre sessant’anni che faccio la pasta”, conferma orgogliosa.
Rivela poi di aver imparato da giovane a fare pochi piatti tradizionali fra i più importanti e di aver poi appreso tante cose in seguito, quando – poco dopo aver raggiunto la maggiore età – aveva raggiunto Torino insieme al marito lasciando Tito, il paesino in provincia di Potenza in cui era nata e cresciuta. Paradossalmente, nei suoi primi anni in città aveva smesso di fare proprio quel che faceva sin da piccola, ossia la pasta a mano. La ragione era che le mancavano troppe cose, troppe, dal tavolo alla farina.
“Quando poi ho iniziato ad andare periodicamente al paese”, conclude, “prendevo la farina e la portavo qui. In realtà lo faccio tutt’ora, perchè è diversa”. Il discorso finisce inevitabilmente per cadere sul mito moderno del “pacco da giù”, andando di nuovo a calpestare il terreno etereo degli ingredienti invisibili.
“Ho notato”, argomenta Pina, “che portando il provolone o le mozzarelle dal Meridione, quando arrivano su sembrano non sapere più di niente. Oppure, mio nipote Simone: lui amava moltissimo il sugo della sua bisnonna, e mi chiedeva sempre “Me lo porti, me lo porti?”, ma una volta qui, dopo averlo mangiato, mi diceva “Non è uguale al suo…”, anche se era proprio quello”.
I nostri ospiti non ne fanno però una questione di provincialismo: “Pure il vino, rimane orrendo, e viceversa: se porti al paese il vino di qua, non è buono per niente. È come se…”, si ferma; “È quello! È l’ingrediente invisibile!”, esclama Gianluca, soddisfatto di vedere confermata la propria teoria nelle parole della madre.

Ma oltre ai fattori incorporei, oggi la coppia di lucani ai fornelli sente la mancanza di un ingrediente reale, tangibile. Mentre nell’aria si sprigiona il profumo strepitoso del pane che tosta, della menta che si scotta e dell’aglio che imbrunisce, infatti, loro sanno che per rendere indimenticabile un piatto già buonissimo ci sarebbe voluto un ulteriore elemento: il peperone crusco.
Si tratta di peperoni lunghi che vengono fatti asciugare al sole in una treccia, sino a diventare tanto croccanti da poter essere sbriciolati e soffritti insieme all’aglio e agli altri ingredienti, ci spiega lei, mentre lui rivela un po’ contrariato di averli cercati in lungo e in largo, per poi trovarli solo in certe boutique alimentari a prezzi folli, intorno agli 80 euro per chilogrammo. “E pensare che a lu Titu te li tirano dietro!”.
La descrizione del paese di Tito ci trasporta in uno scenario bucolico: colline, vigne, campi coltivati, i pomeriggi a raccogliere more e lampascioni, i tetti delle case ricoperti di meraviglie. Giacché il paese sorge su un pendio, ci si può trovare a camminare proprio all’altezza dei tetti delle abitazioni del livello inferiore e sulle tegole si vedono i pomodori distesi a trasformarsi in quel condimento secco e saporito che molti apprezzano, i mazzi di camomilla, le ruote di pane che saranno poi friselle. E i peperoni che diventeranno cruschi. Tutte trasformazioni dovute a un altro ingrediente invisibile, pur se visibilissimo: il sole.
“Nell’orto sul tetto ci piacerebbe poter piantare quei peperoni”, dicono, “ma senza quel sole non verrebbero mai. Se invece fosse un orto immaginario”, parla Gianluca, “ci metterei…un ferretto!”. E la mamma all’istante estrae dalla borsa un’asticella metallica simile a un ferro da maglia, anch’essa portata dalla Basilicata.
A lu Titu c’è una cultura della pasta davvero importante, come dimostrano i celebri strascinati, ma anche i ferretti, termine che designa a un tempo l’attrezzo che si utilizza e il prodotto che se ne ricava.
Era rimasto un pezzetto non utilizzato di quel panetto giallo usato per gli strascinati e Pina ne approfitta per darci una nuova, improvvisata dimostrazione: prende dei tocchetti di impasto, li pressa dolcemente ma decisa uno alla volta con il ferretto, appoggia sul tavolo da lavoro (il tutto richiede circa due secondi scarsi) e tric!, producendo un suono simile al verso di un grillo l’impasto si allunga e si avvolge intorno al bastoncino di metallo.
Ora è diventato un ferretto e la nostra impastatrice umana subito ne ricava un mucchietto alla solita, impressionante velocità. I nostri amici però sono un po’ rammaricati perché il solito, indisponente ripiano di marmo, attutisce il “tric” e non ci permette di sentire “il vero suono dei ferretti”, un suono preciso che per loro è memoria uditiva.

È la seconda volta che, in questo nostro viaggio culinario senza biglietto, ci imbattiamo in un cuoco che utilizza anche l’udito, l’unico fra i cinque sensi a venire solitamente lasciato fuori dalle cucine. La prima fu la cinese Lin, che ascoltava il tegame per capire se la cottura fosse giunta a termine.
Ci ritroviamo in questo momento colmi di stupore e meraviglia, come quando ti cade un velo dagli occhi e vedi qualcosa che avevi sempre avuto davanti a te: “Quindi, il cibo fa rumore?”, ci diciamo, grati di scoprire queste connessioni fra culture in apparenza lontane, connessioni che ci fanno sembrare il mondo più piccolo.
Veniamo riportati all’attimo presente da una notizia che ci rende altrettanto felici: la pasta è pronta! Pina la fa saltare nel condimento e ci serve un piatto che accende vista e olfatto, con colori vivaci e profumi che quasi saziano. Ma solo quasi, per cui procediamo volentieri all’assaggio.
La pasta e i nostri palati non sono certo due sconosciuti che si incontrano per la prima volta; ma proprio perché i nostri sono palati italiani, quindi allenatissimi, sanno riconoscere quando viene offerta loro della pasta buona o meno buona. Quella di oggi li fa sobbalzare di gioia: “l’assaggio” si trasforma rapidamente in una “mangiata a quattro palmenti”.
Per Pina si tratta di consumare quello che giù a Tito non era un piatto delle feste, ma il pasto di ogni giorno. La festa però quotidiana era la preparazione:
“Una cosa che fa la pasta fatta a mano è proprio aggregare”
“Solitamente, non ti metti a farla per una persona sola, per te stesso; quando prepari la pasta a mano, vuol dire che stai aspettando qualcuno, che apri casa tua alle persone che hai invitato”.
Di nuovo veniamo riportati alla nostra amica cinese che, parlando della preparazione dell’impasto dei ravioli, lo definiva un momento in cui “ognuno insegna all’altro e si è contenti”: due culture così distanti si rivelano in realtà mosse dagli stessi istinti, dalla necessità di compiere i medesimi gesti con famigliari e amici. Forse non è un caso che il ragazzo lucano che esprime questi pensieri sia fortemente connesso proprio con la Cina: qui a Torino è il solo socio italiano dell’associazione Nuova Generazione Italo-Cinese che è uno dei punti di riferimenti per la comunità cinese locale, lui stesso ha passato un periodo della sua vita nel paese del dragone.
Gli strascinati rimarranno con noi ancora per un po’, ma sotto forma di persistenza gusto-olfattiva, oltre che di bel ricordo: nei piatti non ce n’è più nemmeno uno. Pina aveva buttato insieme a loro anche quei ferretti realizzati come dimostrazione e, continuando a parlare della tradizione titese della pasta, ci descrive la preparazione della sfoglia per i ravioli o meglio i graviuli, che a differenza di quelli nostrani sono piuttosto grandi, quasi come il palmo di una mano.
A prescindere dalla dimensione, il concetto di “raviolo” è l’ennesimo elemento che va a raccordare la Basilicata dei graviuli e la Cina dei gyoza, ma anche il Piemonte degli agnolotti dove entrambe hanno concluso il proprio viaggio: tutte terre dove i ravioli vengono preparati insieme, da gruppi di persone che impastando dimostrano il proprio affetto reciproco.
Finiamo il nostro piatto e ci sentiamo sazi, ma leggeri. Lo facciamo notare e Gianluca coglie l’occasione per rivendicare la genuinità della cucina del Sud. “Ma certo, molti confondono le ricette delle festività con quelle di tutti i giorni. Se pensi solo alle prime, può sembrare una cucina pesante; ma come vedete non lo è.
Anzi, doveva essere leggera, per le pance e per le tasche, essendo il pasto di contadini che poi andavano a rompersi le braccia nei campi. Pensate, qual è il food cost di questo piatto? Un goccio d’olio e un pugnetto di sale, qualche spicchio d’aglio, qualche fogliolina di menta e tre etti di farina per fare quattro piatti”, dice. “Sì”, interviene la mamma quasi giustificandosi, “tre etti perchè dovevamo preparare giusto un assaggino… a lu Titu se ne fai così poca te la tirano in faccia! Ve lo posso garantire!”.