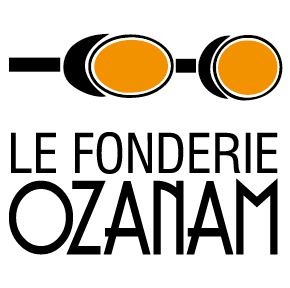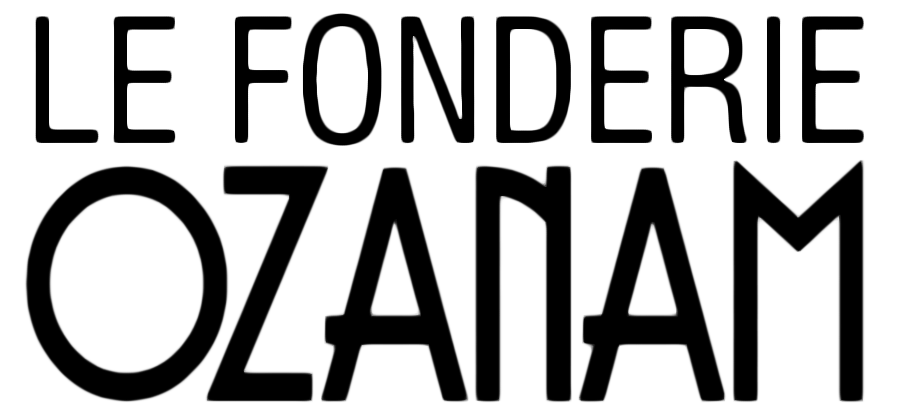Articolo scritto per il progetto cucine del Borgo da Alessandro Salvatico e Caterina Pira.
Il decennio al tramonto è stato quello dello show cooking: la spettacolarizzazione delle preparazioni e soprattutto dell’impiattamento, con modalità spesso più focalizzate sull’entertainement che non sulla didattica della cucina.
Ebbene, quest’oggi nelle cucine Ozanam abbiamo assistito a un vero show cooking, ma autentico, sincero, senza scenografie; così vero che la protagonista non parla neppure l’italiano, eppure ci ha comunque offerto uno spettacolo.
Si chiama Ami, mastica poco la nostra lingua anche perché, nell’anno e mezzo trascorso da quando è arrivata in Italia a raggiungere il marito, non ha avuto molte opportunità di apprendimento in questo senso: governa la casa e la famiglia, il che “è assolutamente normale”, agli occhi del mediatore culturale Ibrahima che la accompagna: “Solo in Italia vedi i mariti che cucinano, la cucina in Senegal è per le donne, lei non ha un lavoro quindi il suo lavoro è la casa”.
Ami è bellissima, di alta statura, bardata di un lungo abito tradizionale giallo ocra con tanto di turbante, il piccolo Fall a cullarsi fasciato sulla sua schiena: sembra una divinità africana, la sua vista da sola colma gli sguardi. Preparerà il thiébou diène (si pronuncia “cebu gen”), il piatto nazionale del Senegal.
Un piatto dalla ritualità impressionante, quasi una danza in cui la protagonista si gira e si volta toccando mille ingredienti, trasformandoli in innumerevoli roff (che in lingua wolof sta per “battuto”) che arricchiranno e copriranno l’odore forte del pesce. “thiébou diène” significa infatti solamente “riso con pesce”, secondo un’usuale modalità africana di chiamare con nomi scarni dei piatti che in realtà prevedono miriadi di ingredienti e tecniche diverse al proprio interno.

Esistono due versioni del piatto, il thiébou diène bou wèh e quello bou honkh, ossia la versione rossa che proveremo oggi e quella bianca, senza pomodoro, “più adatta per chi ha qualche problema di stomaco e con più ingredienti ancora”.
Ami allarga sul piano di lavoro tutto il materiale che ha acquistato dai rivenditori “etnici”. Saltano subito all’occhio i pesci, che sono di diverse specie e che subiranno cotture differenti, per poi finire nell’unico, ricchissimo piatto. C’è davvero un mondo, nel thiébou diène, basta guardarne i pesci per ricavarne una sintesi. C’è la cernia bianca, pregiata e costosa, il dentice africano e un’alaccia che chiama yaboy, un pesce gustoso ma di scarso valore commerciale, tanto che in wolof il termine viene usato anche per indicare una persona da poco: “Quei due sono degli yaboy”, come a dire “non sono nessuno”.
Ami inizia a preparare i vari roff, il suo mortaio è il vaso di Pandora dei triti; ogni volta che finisce di pestare ne esce un battuto diverso: aglio peperoncino rosso pepe sale, peperoncino verde aglio cipolla okra foglie di cipollotto sale pepe prezzemolo, e così via. Con parte di questi farcirà i pesci, che ha squamato e pulito rimuovendone le budella; alcuni li seziona in tre parti, ad altri toglie solo la testa, spingendo poi i condimenti all’interno con le dita.

Già solo in queste prime operazioni c’è tanto di quel lavoro da superare molte altre ricette finite; persino le donne senegalesi spesso vanno a comprare i pesci già farciti. Ami invece parte da zero e lo fa con una leggerezza da danzatrice, covando l’autentico piacere per la cucina che la anima dentro.
Ci racconta di portarlo in sé fin dagli anni verdi. “Un giorno, mia mamma doveva recarsi presso un ufficio comunale per una commissione; uscì presto di casa, doveva rientrare per le undici. Aveva procurato tutto quello che serviva per preparare il thiébou kejak, un piatto a base di pesce essiccato, più costoso e più complesso di quello che facciamo oggi” (Noi ci guardiamo stralunati a pensare a qualcosa di “più complesso” di ciò che stiamo vedendo). “Ma ebbe un contrattempo e quando vidi che non rientrava in tempo, mi accesi il fuoco e provai a prepararlo io.
Quando mia madre rientrò, trovò il piatto già perfettamente pronto, rimase incredula ma non si arrabbiò: mi disse che ero stata bravissima!”. La nostra protagonista avrà avuto circa sei o sette anni all’epoca di questo aneddoto: decisamente precoce.
“Mia mamma amava cucinare; e io pure, ho l’amore per la cucina”.
A spingerla c’era anche una motivazione oggettiva: era l’unica figlia in casa, senza sorelle o fratelli, quindi il aiuto su cui sua madre potesse contare. Ma siccome la sua famiglia non era così numerosa, a volte avanzava del tempo, che in quel caso Ami trascorreva a… cucinare per altre famiglie: “Quando finivo da me, andavo a preparare il pranzo per una signora senza figli”.

Col tempo sarebbe diventato anche il suo lavoro; ma prima, è stata una passione così forte da crearle alcuni problemi, specialmente con la scuola. Se noi siamo abituati a vedere (o magari lo siamo stati noi per primi…) ragazzini che ogni tanto marinano le lezioni per andare a farsi una passeggiata in città o al centro commerciale, ecco che la giovanissima Ami spesso trovava scuse con sua madre ogni qualvolta sapeva che questa avrebbe preparato qualche piatto interessante: “Per guardarla, imparare, e magari cucinare un po’ anche io”, sorride.
Intanto nei molti tegami sul fuoco aggiunge elementi nuovi, quasi alieni: mix di spezie dai profumi insoliti, lo splendido fiore d’ibisco, le patate dolci, l’okra, lo yët (una grossa lumaca di mare essicata) e altri ancora.
Frigge una parte del pesce, un’altra la cucina in umido, monda e cuoce le verdure, prepara una salsa con il tamarindo… Persino la cottura del riso è coreografica: il contenitore forato è posto dentro un tegame più grande, sul fondo del quale cuociono il pesce, le verdure e il pomodoro che daranno profumo ai chicchi. Questi ultimi vengono posti nel contenitore in un modo specifico, formando una sorta di conca al centro. Il tutto viene tappato e i margini vengono avvolti da una sottile striscia di stoffa inumidita per trattenere l’umidità del vapore. Un’opera monumentale, che pare non costare alla cuoca alcuna fatica .

Ibrahima, il mediatore, ogni tanto la sgrida bonariamente perchè non partecipa agli incontri dell’associazione dei senegalesi in Torino, un gruppo coeso che organizza attività culturali in città sin dagli anni ’80; lei risponde che le piace stare a casa. Ma si trova bene in questa città, e anche in Borgo Vittoria, dove suo marito – che lavora come carrellista – vive da vent’anni.
Il bimbo dorme a contatto con la schiena della mamma. “L’ho avuto un po’ tardi”, dice, poi precisa: “…per gli standard senegalesi”. Suo figlio crescerà in un contesto così diverso da quello che vide lei bambina.
Gli scolari senegalesi, e anche Ami quando non marinava per cucinare, a volte fanno strade piuttosto lunghe per raggiungere le scuole. Per merenda si portano dei dolci: Ami ci racconta del thiakry, un cous cous ricavato dal miglio, dai chicchi più grandi e di colore ambrato, che si mischia con lo yogurt.
Sostiene che non le manchino tanti prodotti senegalesi, ormai ci sono commercianti suoi connazionali che li procurano quasi tutti anche nella nostra città. Molti degli elementi gastronomici di cui ci racconta suonano, una volta tanto, autenticamente “esotici” ai nostri occhi.
In Senegal si consuma parecchio miglio e con questo cereale si preparano numerose ricette: oltre al thiakry menzionato sopra, con la farina di miglio si prepara un dolce molto amato di nome lahk, che ricorda un po’ il porridge. Per quanto si tratti di un cereale poco consumato dalle nostre parti, Ami non ha difficoltà ad acquistarlo.

Un ingrediente di cui sente invece la mancanza, che qui non riesce a trovare, è il saba (in wolof chiamato màdd), un frutto sconosciuto in Italia con al suo interno grossi semi dal sapore non dissimile dal tamarindo, che si può consumare con l’aggiunta di sale e che si suole offrire alle donne incinte. Squarci di un ampio mondo su cui abbiamo tutto da imparare.
Quando questa monumentale preparazione è conclusa, il risultato è impiattato in unico grande vassoio da cui ciascuno attingerà, con le mani se fossimo in Senegal, con le posate per chi è meno abituato. E se il lavoro per arrivare al momento dell’assaggio è stato lungo ed articolato, la bontà del thiébou diène di Ami è direttamente proporzionale.
È divino: sapori diversi, con tocchi come il bissap (il calice essiccato del fiore di ibisco) e il tamarindo, rigano la nostra gola di sfumature sconosciute.
Nell’assaggiarlo si sente – lasciatecelo dire, per una volta – l’amore: qualcosa di travolgente ed equilibrato al tempo stesso. Quell’amore di cui ci ha parlato la stessa Ami.

Uno di noi, dopo le prime due o tre cucchiaiate, ha una reazione inconsulta: si mette a piangere. È un pianto di gioia, una risposta spontanea, come quella di Anton Egò quando assaggia la Ratatouille di Remy nel famoso film Disney.
Ad assistere alla scena, ci sono tre senegalesi (ma uno dorme), due italiani che prendono appunti, un cuoco bengalese e una nostra amica olandese. Non è l’inizio di una barzelletta: è la Babele culturale che è frequente si crei in Ozanam e noi ci sentiamo fortunati a essere lì. Ami ride, come fa spesso, indica il thiébou diène e dice: “Buono, buono!”. E in quel momento di tripudio gustativo ed emozionale non siamo sicuri se sia una domanda o un’affermazione, ma non importa.